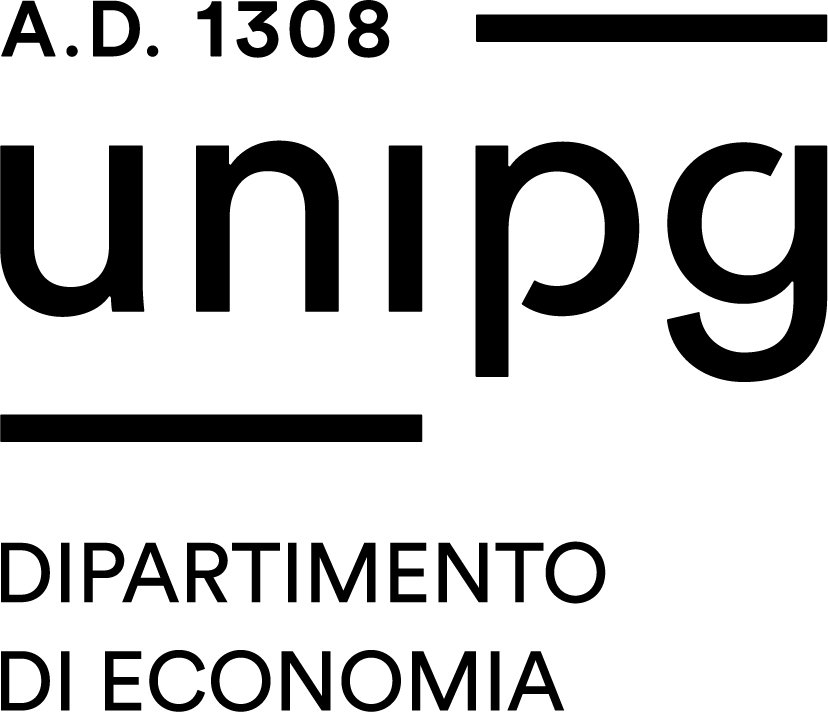Insegnamento ETNOPSICHIATRIA
| Nome del corso | Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale |
|---|---|
| Codice insegnamento | A002696 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile | Massimiliano Minelli |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2024/25 |
| Erogato altro regolamento | |
| Settore | M-DEA/01 |
| Tipo insegnamento | Opzionale (Optional) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il corso affronta gli orientamenti teorici e i metodi della etnopsichiatria, esplorando le relazioni fra disturbi psichici, dispositivi di cura e contesti socioculturali. Sono inoltre approfonditi i problemi, i metodi e le politiche della ricerca e della clinica, per quel che concerne il rapporto fra processi culturali e salute mentale nelle diverse società umane. Nella parte monografica, focalizzando lo sguardo su situazioni concrete e con un taglio storico ed etnografico, sono analizzati i rapporti di potere, l’attivazione delle reti sociali e i processi di cambiamento, in vari contesti della salute mentale globale. Sono inoltre proposti alcuni casi studio, tratti da ricerche etnografiche su processi di deistituzionalizzazione e costruzione di reti di salute mentale comunitaria in Italia e in Brasile. |
| Testi di riferimento | Testo generale: Beneduce B., Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra storia, dominio e cultura, Carocci, Roma, 2019. Parte monografica: Basaglia F., Conferenze brasiliane, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018. Più a scelta 2 articoli tra i seguenti (relativamente ai casi studio affrontati nella parte monografica del corso)*: - Minelli M., “Divorare per non essere divorati”. Etnografia dei processi di deistituzionalizzazione nel campo della salute mentale in Brasile, “Lares”, Vol. 2 (80), 2014, pp. 387-412. - Minelli M., Cartografare paesaggi sonori. Un itinerario etnografico nella rete degli Uditori di Voci, “Anuac. Rivista dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale”, Vol. 6 (2), 2017, pp. 219-243. - Minelli M. Scendere in strada per fare salute e affermare diritti. Esperienze di ricerca e d’azione comunitaria in Brasile, “Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute”, vol. 63. n. 4, ottobre-dicembre 2019, pp. 527-539. - Minelli M. Salute mentale e territorio, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 49, giugno 2020, pp. 129-162. - Minelli M. Asylum 61. Follia, istituzioni, scritture, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, vol. 23, n. 54, dicembre 2022, pp. 111-143. * Gli articoli di rivista sono Open Access e scaricabili in rete (saranno anche resi disponibili in Unistudium) Per chi volesse sostenere l'esame su testi in inglese sono indicati, in alternativa (2 testi a scelta tra i seguenti):¿ Kleinman A., Rethinking Psychiatry. From Cultural Category to Personal Experience, The Free Press - Collier Mac Millan Publisher, New York- London, 1988. Laderman C. - Roseman M. (eds). 1996. The performance of healing, Routledge, London - New York. ¿Lakoff A., Pharmaceutical reason. Knowledge and value in global psychiatry, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.¿ Lambek M. - Strathern A. (Eds.), Bodies and persons. Comparative perspectives from Africa and Melanesia, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ¿Stoller P., Sensuous scholarship, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1997.¿ Young A., The harmony of illusions. Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton University Press, Princeton NJ., 1995. |
| Obiettivi formativi | L’insegnamento intende fornire le basi conoscitive nel campo della Etnopsichiatria e permettere di sviluppare approcci aggiornati a problemi e metodi della ricerca, per quel che concerne il rapporto fra processi culturali e salute mentale. Le principali conoscenze (Descrittore di Dublino 1) acquisite saranno: conoscenza di orientamenti teorici e metodi della etnopsichiatria; conoscenza di diversi approcci a sofferenza e presa in carico nel panorama delle migrazioni. Le principali abilità acquisite (capacità di applicare le conoscenze acquisite, Descrittore di Dublino 2, e di adottare con autonomia di giudizio l’opportuno approccio, Descrittore di Dublino 3) saranno: - capacità di analizzare situazioni complesse di presa in carico e di attivazione di reti sociali a partire da forme specifiche di sofferenza sociale; - capacità di esplorare da diverse prospettive le relazioni di cura tra diversi soggetti; - capacità di interpretare gli scambi materiali e simbolici nelle relazioni terapeutiche; - capacità di leggere i processi di trasformazione implicati nelle pratiche rituali e nei dispositivi psicoterapeutici; - capacità di riflettere sul posizionamento del ricercatore e sulle dislocazioni degli altri diversi soggetti nei contesti terapeutici. |
| Prerequisiti | Al fine di saper comprendere e per meglio affrontare il corso, che ha un orientamento critico e riflessivo rispetto alle relazioni tra società, culture e modalità di intervento sui disturbi psichici, lo studente deve possedere nozioni di base concernenti le teorie delle scienze sociali e la storia dell’antropologia culturale. Questo prerequisito è valido sia per gli studenti frequentanti sia per i non frequentanti. |
| Metodi didattici | Il corso è organizzato nel seguente modo: lezioni frontali; attività laboratoriale e gruppi di discussione; visione di materiali etnografici audiovisuali come integrazione delle lezioni frontali. |
| Altre informazioni | Durante il corso, oltre ai materiali di ricerca e alla proiezione di prodotti audiovisuali di taglio etnografico, saranno fornite ulteriori informazioni bibliografiche per approfondimenti. Si consiglia ai non frequentanti di contattare il docente per il programma d'esame recandosi presso lo studio nell'orario di ricevimento. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame consiste in una prova orale finale, che si sviluppa come una discussione-colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e approfonditi sui testi consigliati. La prova serve per accertare il livello di conoscenza dei concetti e degli strumenti analitici della etnopsichiatria nonché la capacità dello studente di riflettere su dinamiche transculturali in contesti di salute mentale comunitaria. Il colloquio permetterà inoltre di valutare i livelli di conoscenza, comprensione e capacità di analisi critica in merito ai la disagio psichico e dalla salute mentale. Il colloquio di durata non superiore a circa 30 minuti è finalizzato ad accertare: - il livello di conoscenza dei contenuti teorici del corso (descrittore di Dublino 1); - il livello di competenza nell’esporre le proprie conoscenze (descrittore di Dublino 2); - l’autonomia di giudizio (descrittore di Dublino 3). - la capacità dello studente di rispondere con proprietà di linguaggio alle domande proposte dalla Commissione, di sostenere un rapporto dialettico durante il colloquio e di dimostrare capacità logico-deduttive e di sintesi nell'esposizione (descrittore di Dublino 4). La valutazione finale verrà stabilita dalla Commissione in trentesimi. Studenti con disabilità e/o con DSA: per la modalità di svolgimento delle prove di verifica, gli studenti possono giovarsi delle tecnologie inclusive, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla normativa. Tecnologie, strumenti e misure vanno richiesti e concordarti con il docente con congruo anticipo rispetto alle prove. Per le informazioni generali, consultare i Servizi di Ateneo alla pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa e mettersi in contatto con il Referente per il Dipartimento. Nota: Nel caso in cui lo studente intenda anticipare l’esame in un anno precedente a quello programmato nel piano di studio, si raccomanda di frequentare il ciclo delle lezioni e di sostenere l’esame nel primo appello utile dopo che le lezioni medesime siano terminate, nel rispetto quindi del semestre di programmazione dell’insegnamento. |
| Programma esteso | Il corso affronta gli orientamenti teorici e i metodi della etnopsichiatria, esplorando le relazioni fra disturbi psichici, dispositivi di cura e contesti socioculturali. Sono inoltre approfonditi i problemi, i metodi e le politiche della ricerca e della clinica, per quel che concerne il rapporto fra processi culturali e salute mentale nelle diverse società umane. Nella parte monografica, focalizzando lo sguardo su situazioni concrete e con un taglio storico ed etnografico, sono analizzati i rapporti di potere, l’attivazione delle reti sociali e i processi di cambiamento, in vari contesti della salute mentale globale. Sono inoltre proposti alcuni casi studio, tratti da ricerche etnografiche su processi di deistituzionalizzazione e costruzione di reti di salute mentale comunitaria in Italia e in Brasile. Gli itinerari verso una salute mentale senza istituzioni segreganti richiedono una attività collettiva permanente per deistituzionalizzare le pratiche quotidiane e per mobilitare le risorse collettive. Tale attività ha bisogno di favorire il dialogo tra le diverse pratiche sociali e saperi minori, che non possono essere integrati in una rigida struttura biomedica. Le nuove strategie di azione, affinché siano avanzata e creativa, hanno bisogno di concentrarsi sul rapporto tra salute primaria e politiche comunitarie di salute mentale. A questo proposito, il lavoro etnografico è essenziale per la produzione di pensiero critico e per evidenziare, in divenire, le interazioni tra la pratica ordinaria della psichiatria, movimenti sociali e il processo costituente delle riforme sanitarie nei sistemi pubblici di salute. “ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE NELLA SALUTE MENTALE GLOBALE” Il corso è articolato in due parti. La prima parte affronta gli orientamenti teorici e i metodi della Etnopsichiatria: un terreno di confine in cui diverse discipline (antropologia, psicologia, psichiatria) esplorano le relazioni fra disturbi psichici, dispositivi di cura e contesti socioculturali. In una prospettiva storica e con una definizione etnografica delle aree d’interesse, sono inoltre approfonditi i problemi, i metodi e le politiche della ricerca, per quel che concerne il rapporto fra processi culturali e salute mentale nelle diverse società umane. Nella seconda parte, focalizzando lo sguardo su situazioni concrete e con un taglio storico ed etnografico, sono analizzati i rapporti di potere, l’attivazione delle reti sociali e i processi di cambiamento, in vari contesti della salute mentale investiti da processi di liberazione e deistituzionalizzazione. In questo ambito, focalizzando lo sguardo su situazioni concrete e con un taglio storico ed etnografico, sono analizzati i rapporti di potere, l’attivazione delle reti sociali e i processi di cambiamento nella salute pubblica e nelle reti comunitarie di cura. Sono inoltre proposti alcuni casi studio, tratti da ricerche etnografiche su differenti dispositivi terapeutici e contesti rituali in Italia e Brasile, ove gli agenti sociali sono collettivamente coinvolti in pratiche trasformative. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | 3,4,5 |