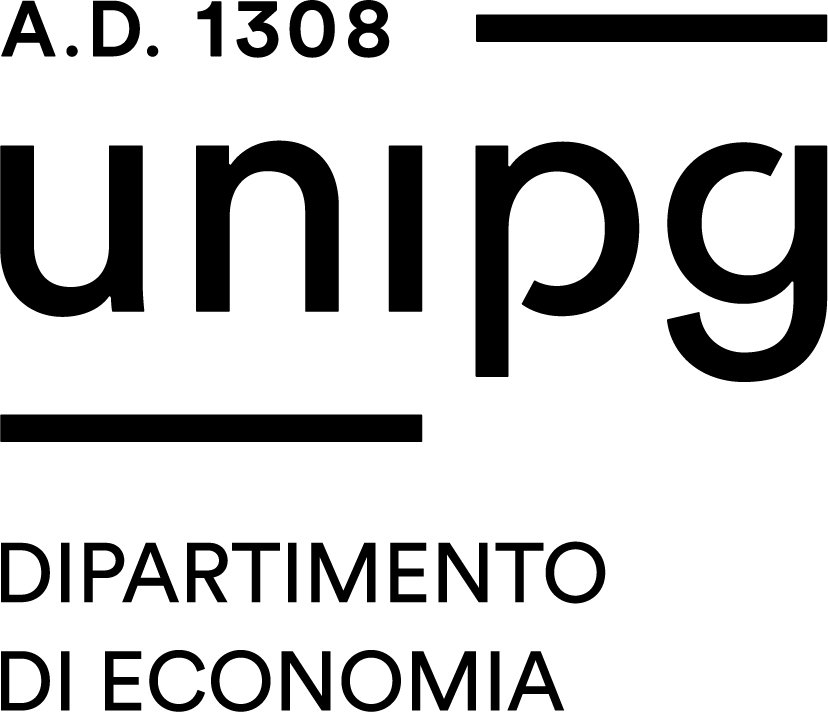Insegnamento CHIMICA ORGANICA II
| Nome del corso | Farmacia |
|---|---|
| Codice insegnamento | A002954 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile | Claudio Santi |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2022 |
| Erogato | Erogato nel 2023/24 |
| Attività | Base |
| Ambito | Discipline chimiche |
| Settore | CHIM/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Struttura delle molecole organiche, nomenclatura, sintesi e reattività di composti carbossilici, carbonilici, aromatici, eterocicli, carboidrati, aminoacidi e proteine |
| Testi di riferimento | Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore CHIMICA ORGANICA Zanichelli 4a ed Brown, Iverson, Anslyn, Foote CHIMICA ORGANICA Edises, VI edizione |
| Obiettivi formativi | Conoscere la nomenclatura le reazioni che caratterizzano la sintesi e chimismo di composti carbossilici, carbonilici, aromatici, eterocicli, amine, carboidrati, aminoacidi e proteine, inclusi gli aspetti stereochimici correlati. Essere in grado di applicare i principi acquisiti anche allo studio di molecole di interesse biochimico e farmaceutico. |
| Prerequisiti | Lo studente essere a conoscenza delle nozioni base di chimica generale ed organica, in particolare dovrà aver sostenuto gli esami di Chimica Generale e Chimica Organica I |
| Metodi didattici | Lezioni frontali in cui il docente illustrerà tutti gli argomenti del corso, illustrando alcuni esercizi esemplificativi |
| Altre informazioni | Attività di didattica integrativa: Saranno previste esercitazioni durante lo svolgimento del corso, alla fine del corso e prima degli appelli della sessione estiva. Prima degli altri appelli il docente e gli addetti all'attività didattica integrativa saranno a disposizione degli studenti per chiarimenti e spiegazioni. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | La verifica dell'apprendimento consisterà in una prova scritta alla quale, se sufficiente, seguirà un colloquio orale. Lo studente dovrà saper fornire la corretta nomenclatura e configurazione di molecole organiche, inoltre dovrà essere in grado di risolvere esercizi in cui verrà richiesto di saper utilizzare le nozioni apprese mostrando padronanza dei concetti studiati. Se la situazione pandemica lo richiederà, le modalità di esame potranno subire variazioni in accordo alle indicazioni di Ateneo Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Benzene e aromaticita`: Nomenclatura dei derivati del benzene - Struttura ed energia di risonanza del benzene: un primo sguardo all’aromaticita` - Orbitali molecolari p del benzene - La regola di Hu¨ckel - Sintesi di derivati del benzene: sostituzione elettrofila aromatica - Alogenazione del benzene: la necessita` di un catalizzatore - Nitrazione e solfonazione del benzene - Alchilazione di Friedel-Crafts - Limiti delle alchilazioni di Friedel-Crafts - Acilazione di Friedel-Crafts. Controllo della regioselettivita` dei sostituenti:- Effetto attivante o disattivante dei sostituenti sull’anello benzenico - Effetti orientanti elettron-donatori di gruppi alchilici -Effetti orientanti di sostituenti coniugati all’anello benzenico -elettrofilo su benzeni disostituiti Aldeidi e chetoni : Il gruppo carbonilico - Nomenclatura di aldeidi e chetoni - La struttura del gruppo carbonilico - Preparazione di aldeidi e chetoni - Reattivita` del gruppo carbonilico: meccanismi di addizione - L’addizione di acqua e la formazione di idrati - L’addizione di alcoli e la formazione di emiacetali e acetali -Acetali come gruppi protettivi - Addizione nucleofila di ammoniaca e dei suoi derivati - Deossigenazione del gruppo carbonilico - Addizione di acido cianidrico a dare cianoidrine - Addizioni di ilidi di fosforo: la reazione di Wittig Ossidazione con acidi perossocarbossilici: l’ossidazione di Baeyer-Villiger - Saggi ossidativi per le aldeidi Enoli, enolati e la condensazione aldolica Aldeidi e chetoni a,ß-insaturi - Acidita` di aldeidi e chetoni: gli ioni enolato - Equilibri cheto-enolici L’alogenazione di aldeidi e chetoni- Alchilazione di aldeidi e chetoni -Attacco di enolati alla funzione carbonilica: la condensazione aldolica - Condensazione aldolica incrociata -Addizioni coniugate ad aldeidi e chetoni a,ß-insaturi -Addizioni 1,2 e 1,4 di reagenti organometallici- Addizione coniugata di ioni enolati: l’addizione di Michael e l’anellazione di Robinson Acidi carbossilici – La nomenclatura degli acidi carbossilici-Proprieta` strutturali e fisiche degli acidi carbossilici-Carattere acido e basico degli acidi carbossilici- Metodi per l’introduzione del gruppo funzionale carbossilico-La sostituzione al carbonio carbossilico: il meccanismo di addizione- eliminazione - Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici e anidridi - Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi, alogenuri, anidridi, sinetesi e reattività - Riduzione di acidi carbossilici con litio alluminio idruro - Bromurazione nella posizione adiacente al gruppo carbossilico: la reazione di Hell-Volhard-Zelinsky -Attivita` biologica degli acidi carbossilici Chimica dei sostituenti del benzene Alchilbenzeni, fenoli e benzenammine Gli enolati degli esteri e la condensazione di Claisen - Sintesi di composti ß-dicarbonilici; equivalenti di acil-anioni – Acidi Grassi - Carboidrati - Composti polifunzionali in natura - Amminoacidi, peptidi, proteine e acidi nucleici. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile |