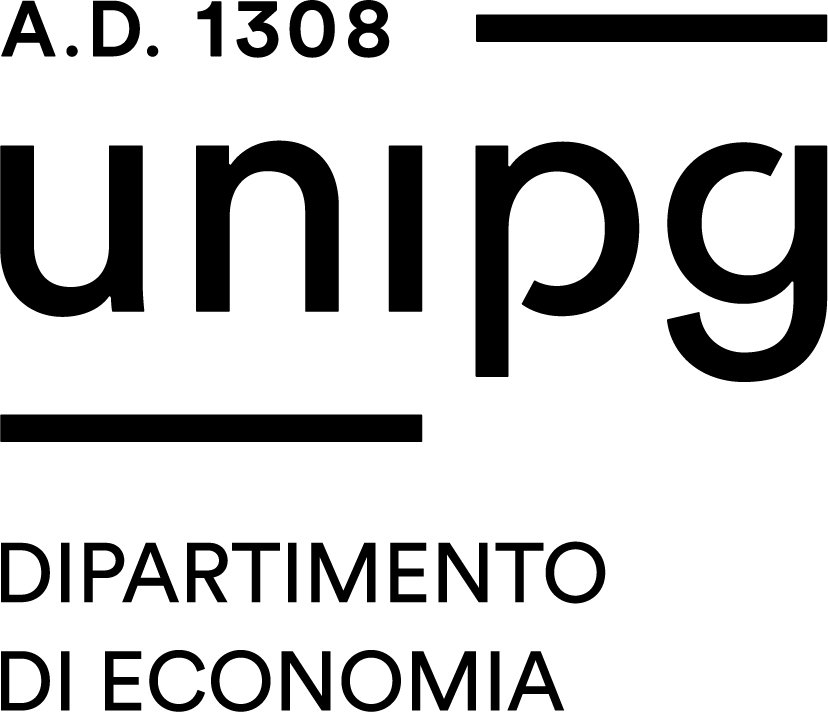Insegnamento STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
| Nome del corso | Filosofia e scienze e tecniche psicologiche |
|---|---|
| Codice insegnamento | GP003409 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 12 |
| Regolamento | Coorte 2021 |
| Erogato | Erogato nel 2021/22 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline filosofiche |
| Settore | M-FIL/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Suddivisione |
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA - Cognomi A-C
| Codice | GP003409 |
|---|---|
| CFU | 12 |
| Docente responsabile | Furia Valori |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline filosofiche |
| Settore | M-FIL/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Significato e interpretazione nella filosofia contemporanea: un percorso tra filosofia analitica e continentale |
| Testi di riferimento | 1) Lo studente dovrà provvedere a una preparazione di base attraverso lo studio di un manuale di Storia della filosofia contemporanea (ad. es., Giovanni Reale e Dario Antiseri, Storia della filosofia contemporanea, La Scuola, Brescia, oppure Mori-Cambiano, Storia della filosofia contemporanea, Laterza. Roma-Bari, ult. ed.). 2) F. Nietzsche, Interpretazione e oltreuomo, Antologia di scritti nietzscheani a cura e con introduzione di F. Valori, Morlacchi Perugia 2014. 3) H. G. Gadamer, Soggetto, linguaggio e interpretazione, Antologia di testi di gadameriani a cura e con introduzione di F. Valori, Morlacchi, Perugia 2019. Si consiglia anche 4) F. D'Agostini, Analitici e continentali. |
| Obiettivi formativi | Lo studente dovrà acquisire consapevolezza critica dei principali snodi argomentativi e problematici caratterizzanti la storia della filosofia contemporanea e il dibattito sui temi del significato e dell’interpretazione.Acquisizione significativa dei contenuti storico-filosofici della disciplina; sviluppo della capacità di orientamento elaborativo-critico ed interpretativo. Analisi critica delle principali metodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica della filosofia, anche in riferimento allo specifico ruolo dell'insegnante, ai nodi concettuali, epistemologici e didattici dell'insegnamento e apprendimento delle discipline di interesse, e in funzione dello sviluppo delle capacita` semiotiche nonche´ dell'ampliamento delle potenzialita` espressive e conoscitive nell'ambito disciplinare specifico. Progettazione e sviluppo di attivita` di insegnamento della filosofia: illustrazione dei principi e delle metodologie per la costruzione di attivita` e piu` in generale di un curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e di consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione nelle discipline di interesse. Metodologia della didattica interdisciplinare: rapporti tra filosofia e altre forme del sapere; filosofia e scienze, filosofia e arte, filosofia e storia, filosofia e discussione pubblica. Studio dei processi di insegnamento e apprendimento della filosofia mediati dall'uso delle tecnologie, con particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali, allo specifico ruolo dell'insegnante, ai nodi concettuali, epistemologici e didattici. Analisi delle potenzialita` e criticita` dell'uso di strumenti tecnologici per l'insegnamento e apprendimento della filosofia. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, seminari |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame orale. Verrà fatta almeno una esercitazione, facoltativa, aperta ai frequentanti e non frequentanti, e agli studenti degli anni acc. precedenti. La datra verrà decisa con i frequentanti e ne verrà data ampia diffusione sia sul sito del Dipartimento www.fissuf.unipg.it, sia in bacheca. Ulteriori indicazioni verranno date dal docente durante le lezioni. |
| Programma esteso | Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, il Positivismo sociale ed evoluzionistico, Lo storicismo, Lo spiritualismo, Bergson, Storicismo tedesco, Neoidealismo anglo-americano, La psicanalisi di Freud, La filosofia della scienza e l’epistemologia post-positivistica, La fenomenologia di Husserl, Heidegger, L’esistenzialismo, Gadamer e l’ermeneutica filosofica, Ricoeur, Levinas, la filosofia analitica (Frege, Russell, Wittgenstein I e II, Austin, Grice, Quine). |
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA - Cognomi D-L
| Codice | GP003409 |
|---|---|
| CFU | 12 |
| Docente responsabile | Serena Meattini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline filosofiche |
| Settore | M-FIL/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Le vie della filosofia contemporanea |
| Testi di riferimento | 1) Lo studente dovrà provvedere a una preparazione di base attraverso lo studio di un manuale di Storia della filosofia contemporanea (ad. es., Giovanni Reale e Dario Antiseri, Storia della filosofia contemporanea, La Scuola, Brescia o equivalenti). 2) Uno a scelta tra i seguenti autori e temi (portando quanto indicato nella sessione scelta, una tra le seguenti: Gadamer, Ricoeur, Simone Weil) A) Gadamer: verità e metodo H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000 (Introduzione e prima parte: da 19 a 108) B) Ricoeur: uno a scelta tra B1) P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book 1986: “Introduzione. Esistenza ed ermeneutica”, pp. 17-40 e “Parte seconda. Ermeneutica e psicanalisi”, pp. 115-224; [rapporto tra ermeneutica e psicanalisi intorno al tema dell’interpretazione] oppure B2) P. Ricoeur, dal testo all’azione, Jaca Book 1989: “Dell’interpretazione” + “Per una fenomenologia ermeneutica”, pp. 11-133; [confronto tra le diverse posizioni ermeneutiche: Ricoeur, Heidegger, Gadamer];(Per approfondire: D. Jervolino, Introduzione a Ricoeur, Morcelliana, 2003). Materiale fornito a lezione. C) S. Weil, La persona e il Sacro, Adelphi, Milano 2012 oppure M. Marianelli, Introduzione: S. Weil protagonista della filosofia del 900. Ritrovare l’Umano, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 330-341) oppure M. Marianelli, Tra hasard e necessità: l’ontologia weiliana come ricerca di intermediari, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 341-370). I Docenti forniranno ulteriori indicazioni durante lo svolgimento delle lezioni |
| Obiettivi formativi | Lo studente dovrà acquisire consapevolezza critica dei principali snodi argomentativi e problematici caratterizzanti la storia della filosofia contemporanea e il dibattito sui temi del significato e dell’interpretazione. Acquisizione significativa dei contenuti storico-filosofici della disciplina; sviluppo della capacità di orientamento elaborativo-critico ed interpretativo. Metodologia della didattica interdisciplinare: rapporti tra filosofia e altre forme del sapere; filosofia e scienze, filosofia e arte, filosofia e storia, filosofia e discussione pubblica. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, seminari |
| Altre informazioni | Le Lezioni si svolgeranno presso Il Dipartimento Fissuf o, se necessario, in modalità blended o on line. Per maggiori informazioni si prega di visionare il sito. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria ma altamente consigliata nonché condizione per l'accesso all'eventuale esonero che precede l'esame finale; anche per le ore di didattica integrativa proposte la frequenza non è obbligatoria ma altamente consigliata. Il programma dettagliato e le indicazioni supplementari (testi di riferimento e letture che verranno proposti nel corso delle lezioni) sono reperibili nel portale Unistudium (https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/) È possibile iscriversi e fare login con le credenziali di Ateneo: l’iscrizione è obbligatoria perché è la piattaforma attraverso la quale si sosterrà la prova finale. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Lo svolgimento dell'esame sarà in forma scritta: prova su piatttaforma online di 40 minuti. Il principale oggetto di valutazione concerne l'acquisizione della capacità critica e dell'individuale utilizzo delle metodologie e degli strumenti acquisiti durante il corso, mediante la lettura critica e metodica dei testi indicati nel programma e secondo il metodo fenomenologico illustrato durante lo svolgimento delle Lezioni. La valutazione delle competenze acquisite durante l'esame è misurata in trentesimi. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Il corso intende porre l’attenzione sulle principali vie della filosofia contemporanea, con particolare attenzione ai seguenti autori e temi: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, il Positivismo sociale e evoluzionistico, Nietzsche, Lo storicismo, Lo spiritualismo, Bergson, Marcel, Blondel, Il personalismo (Mounier e Maritain); Storicismo tedesco, riabilitazione della filosofia pratica e la scuola di Francoforte; Freud e la psicanalisi, La filosofia della scienza e l’epistemologia post-positivistica, La fenomenologia di Husserl e Heidegger, vie alternative della fenomenologia (Simone Weil e Guardini), l’esistenzialismo, Wittgenstein e la filosofia analitica, il pragmatismo. L’ermeneutica filosofica - Gadamer e Derrida-Paul Ricoeur; vie dell’estetica contemporanea. |
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA - Cognomi M-P
| Codice | GP003409 |
|---|---|
| CFU | 12 |
| Docente responsabile | Serena Meattini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline filosofiche |
| Settore | M-FIL/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Le vie della filosofia contemporanea |
| Testi di riferimento | 1) Lo studente dovrà provvedere a una preparazione di base attraverso lo studio di un manuale di Storia della filosofia contemporanea (ad. es., Giovanni Reale e Dario Antiseri, Storia della filosofia contemporanea, La Scuola, Brescia o equivalenti). 2) Uno a scelta tra i seguenti autori e temi (portando quanto indicato nella sessione scelta, una tra le seguenti: Gadamer, Ricoeur, Simone Weil) A) Gadamer: verità e metodo H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000 (Introduzione e prima parte: da 19 a 108) B) Ricoeur: uno a scelta tra B1) P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book 1986: “Introduzione. Esistenza ed ermeneutica”, pp. 17-40 e “Parte seconda. Ermeneutica e psicanalisi”, pp. 115-224; [rapporto tra ermeneutica e psicanalisi intorno al tema dell’interpretazione] oppure B2) P. Ricoeur, dal testo all’azione, Jaca Book 1989: “Dell’interpretazione” + “Per una fenomenologia ermeneutica”, pp. 11-133; [confronto tra le diverse posizioni ermeneutiche: Ricoeur, Heidegger, Gadamer];(Per approfondire: D. Jervolino, Introduzione a Ricoeur, Morcelliana, 2003). Materiale fornito a lezione. C) S. Weil, La persona e il Sacro, Adelphi, Milano 2012 oppure M. Marianelli, Introduzione: S. Weil protagonista della filosofia del 900. Ritrovare l’Umano, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 330-341) oppure M. Marianelli, Tra hasard e necessità: l’ontologia weiliana come ricerca di intermediari, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 341-370). I Docenti forniranno ulteriori indicazioni durante lo svolgimento delle lezioni |
| Obiettivi formativi | Lo studente dovrà acquisire consapevolezza critica dei principali snodi argomentativi e problematici caratterizzanti la storia della filosofia contemporanea e il dibattito sui temi del significato e dell’interpretazione. Acquisizione significativa dei contenuti storico-filosofici della disciplina; sviluppo della capacità di orientamento elaborativo-critico ed interpretativo. Metodologia della didattica interdisciplinare: rapporti tra filosofia e altre forme del sapere; filosofia e scienze, filosofia e arte, filosofia e storia, filosofia e discussione pubblica. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, seminari |
| Altre informazioni | Le Lezioni si svolgeranno presso Il Dipartimento Fissuf o, se necessario, in modalità blended o on line. Per maggiori informazioni si prega di visionare il sito. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria ma altamente consigliata nonché condizione per l'accesso all'eventuale esonero che precede l'esame finale; anche per le ore di didattica integrativa proposte la frequenza non è obbligatoria ma altamente consigliata. Il programma dettagliato e le indicazioni supplementari (testi di riferimento e letture che verranno proposti nel corso delle lezioni) sono reperibili nel portale Unistudium (https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/) È possibile iscriversi e fare login con le credenziali di Ateneo: l’iscrizione è obbligatoria perché è la piattaforma attraverso la quale si sosterrà la prova finale. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Lo svolgimento dell'esame sarà in forma scritta: prova su piatttaforma online di 40 minuti. Il principale oggetto di valutazione concerne l'acquisizione della capacità critica e dell'individuale utilizzo delle metodologie e degli strumenti acquisiti durante il corso, mediante la lettura critica e metodica dei testi indicati nel programma e secondo il metodo fenomenologico illustrato durante lo svolgimento delle Lezioni. La valutazione delle competenze acquisite durante l'esame è misurata in trentesimi. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Il corso intende porre l’attenzione sulle principali vie della filosofia contemporanea, con particolare attenzione ai seguenti autori e temi: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, il Positivismo sociale e evoluzionistico, Nietzsche, Lo storicismo, Lo spiritualismo, Bergson, Marcel, Blondel, Il personalismo (Mounier e Maritain); Storicismo tedesco, riabilitazione della filosofia pratica e la scuola di Francoforte; Freud e la psicanalisi, La filosofia della scienza e l’epistemologia post-positivistica, La fenomenologia di Husserl e Heidegger, vie alternative della fenomenologia (Simone Weil e Guardini), l’esistenzialismo, Wittgenstein e la filosofia analitica, il pragmatismo. L’ermeneutica filosofica - Gadamer e Derrida-Paul Ricoeur; vie dell’estetica contemporanea. |
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA - Cognomi Q-Z
| Codice | GP003409 |
|---|---|
| CFU | 12 |
| Docente responsabile | Rossella Saccoia |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline filosofiche |
| Settore | M-FIL/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Le vie della filosofia contemporanea |
| Testi di riferimento | 1) Lo studente dovrà provvedere a una preparazione di base attraverso lo studio di un manuale di Storia della filosofia contemporanea (ad. es., Giovanni Reale e Dario Antiseri, Storia della filosofia contemporanea, La Scuola, Brescia o equivalenti). 2) Uno a scelta tra i seguenti autori e temi (portando quanto indicato nella sessione scelta, una tra le seguenti: Gadamer, Ricoeur, Simone Weil) A) Gadamer: verità e metodo H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000 (Introduzione e prima parte: da 19 a 108) B) Ricoeur: uno a scelta tra B1) P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book 1986: “Introduzione. Esistenza ed ermeneutica”, pp. 17-40 e “Parte seconda. Ermeneutica e psicanalisi”, pp. 115-224; [rapporto tra ermeneutica e psicanalisi intorno al tema dell’interpretazione] oppure B2) P. Ricoeur, dal testo all’azione, Jaca Book 1989: “Dell’interpretazione” + “Per una fenomenologia ermeneutica”, pp. 11-133; [confronto tra le diverse posizioni ermeneutiche: Ricoeur, Heidegger, Gadamer];(Per approfondire: D. Jervolino, Introduzione a Ricoeur, Morcelliana, 2003). Materiale fornito a lezione. C) S. Weil, La persona e il Sacro, Adelphi, Milano 2012 oppure M. Marianelli, Introduzione: S. Weil protagonista della filosofia del 900. Ritrovare l’Umano, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 330-341) oppure M. Marianelli, Tra hasard e necessità: l’ontologia weiliana come ricerca di intermediari, in «Studium», anno 116 - mag./giu. 2020 - n. 3 (pp. 341-370). I Docenti forniranno ulteriori indicazioni durante lo svolgimento delle lezioni |
| Obiettivi formativi | Lo studente dovrà acquisire consapevolezza critica dei principali snodi argomentativi e problematici caratterizzanti la storia della filosofia contemporanea e il dibattito sui temi del significato e dell’interpretazione. Acquisizione significativa dei contenuti storico-filosofici della disciplina; sviluppo della capacità di orientamento elaborativo-critico ed interpretativo. Metodologia della didattica interdisciplinare: rapporti tra filosofia e altre forme del sapere; filosofia e scienze, filosofia e arte, filosofia e storia, filosofia e discussione pubblica. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, seminari |
| Altre informazioni | Le Lezioni si svolgeranno presso Il Dipartimento Fissuf o, se necessario, in modalità blended o on line. Per maggiori informazioni si prega di visionare il sito. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria ma altamente consigliata nonché condizione per l'accesso all'eventuale esonero che precede l'esame finale; anche per le ore di didattica integrativa proposte la frequenza non è obbligatoria ma altamente consigliata. Il programma dettagliato e le indicazioni supplementari (testi di riferimento e letture che verranno proposti nel corso delle lezioni) sono reperibili nel portale Unistudium (https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/) È possibile iscriversi e fare login con le credenziali di Ateneo: l’iscrizione è obbligatoria perché è la piattaforma attraverso la quale si sosterrà la prova finale. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Lo svolgimento dell'esame sarà in forma scritta: prova su piatttaforma online di 40 minuti. Il principale oggetto di valutazione concerne l'acquisizione della capacità critica e dell'individuale utilizzo delle metodologie e degli strumenti acquisiti durante il corso, mediante la lettura critica e metodica dei testi indicati nel programma e secondo il metodo fenomenologico illustrato durante lo svolgimento delle Lezioni. La valutazione delle competenze acquisite durante l'esame è misurata in trentesimi. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Il corso intende porre l’attenzione sulle principali vie della filosofia contemporanea, con particolare attenzione ai seguenti autori e temi: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, il Positivismo sociale e evoluzionistico, Nietzsche, Lo storicismo, Lo spiritualismo, Bergson, Marcel, Blondel, Il personalismo (Mounier e Maritain); Storicismo tedesco, riabilitazione della filosofia pratica e la scuola di Francoforte; Freud e la psicanalisi, La filosofia della scienza e l’epistemologia post-positivistica, La fenomenologia di Husserl e Heidegger, vie alternative della fenomenologia (Simone Weil e Guardini), l’esistenzialismo, Wittgenstein e la filosofia analitica, il pragmatismo. L’ermeneutica filosofica - Gadamer e Derrida-Paul Ricoeur; vie dell’estetica contemporanea. |