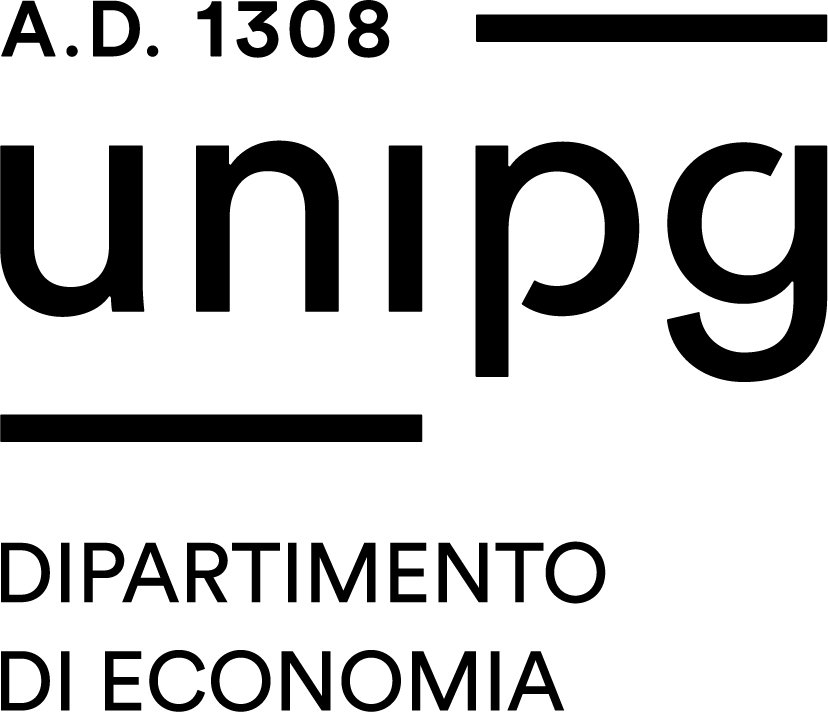Insegnamento IMMUNOPATOLOGIA
| Nome del corso | Biologia |
|---|---|
| Codice insegnamento | A001034 |
| Curriculum | Biosanitario |
| Docente responsabile | Katia Fettucciari |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2023/24 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | MED/04 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il Sistema Immunitario in Fisiologia: risposte immunitarie umorale e cellulo-mediata nella difesa verso i patogeni. Il Sistema Immunitario In Patologia: alterazioni della risposta immunitaria nell’autoimmunità, nelle malattie correlate alle risposte immunitarie nell'intestino e nei diversi tipi di ipersensibilità, esempi di patologie umane. Immunologia dei Trapianti. Immunità e Tumori. |
| Testi di riferimento | Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Immunologia Cellulare e Molecolare. Decima Edizione, 2022, Edra Editore. Murphy K., Weaver C.. Janeway C.A., Immunobiologia. Nona edizione, 2019, Piccin Editore. |
| Obiettivi formativi | Al termine del corso lo studente dovrà conoscere e comprendere i meccanismi fisiopatologici, cellulari e molecolari, che sottostanno alle risposte immunitarie e alle alterazioni delle risposte immunitarie nei diversi tipi di ipersensibilità e nell’autoimmunità. Dovrà quindi avere l'abilità di associare i meccanismi effettori dell'immunità alle diverse situazioni patologiche. Lo studente dovrà inoltre conoscere e comprendere il ruolo del sistema immunitario nelle malattie correlate alle risposte immunitarie nell'intestino, nel rigetto dei trapianti e nel controllo dei tumori. |
| Prerequisiti | Al fine di comprendere i contenuti trattati nel Corso di Immunopatologia, lo studente deve possedere conoscenze di Biologia Cellulare e Molecolare (indispensabile), Biochimica (indispensabile), Genetica (importante), Anatomia (utile), Istologia (utile). |
| Metodi didattici | Lezioni Frontali in aula su tutti gli argomenti di Immunologia con proiezioni e discussione di diapositive. Alcuni selezionati argomenti saranno poi approfonditi e ridiscussi dagli studenti. |
| Altre informazioni | L’orario di inizio e termine delle lezioni, la sede di svolgimento delle lezioni e il calendario degli esami sono pubblicati nel sito del Corso di Laurea: http://www.chm.unipg.it/laurea-magistrale-in-biologia Orario e sede del ricevimento studenti: Il docente riceve gli studenti su appuntamento che sarà concordato per e-mail: katia.fettucciari@unipg.it, o telefonicamente al N.: 0755858124. Il ricevimento avrà luogo nello Studio del Docente situato nell'Edificio B - quarto piano del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, San Sisto-Perugia Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina: https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L’esame prevede una prova orale. La prova orale consisterà in una discussione della durata di circa 25-30 minuti, finalizzata ad accertare il livello di conoscenza e la capacità di comprensione dei contenuti del corso, nonché la capacità di sintesi ed integrazione delle conoscenze, raggiunti dallo studente. La prova orale consentirà anche di valutare la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio dello studente. La prova orale consisterà in quattro domande su argomenti svolti durante il corso. Una di queste domande verterà sulle strutture molecolari del sistema immunitario e sulla loro funzione integrata nel mediare i meccanismi cellulari e molecolari delle risposte immunitarie. Tre altre domande verteranno sui meccanismi alla base delle alterazioni delle risposte immunitarie e sul ruolo del sistema immunitario nell’ipersensibilità, nell’autoimmunità, nel rigetto dei trapianti e nel controllo dei tumori. "Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa)". |
| Programma esteso | -CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA IMMUNITARIO- Immunità innata e specifica. Caratteristiche principali e meccanismi effettori delle risposte immuni specifiche. Fasi della risposta immunitaria. -IMMUNOGLOBULINE- Struttura molecolare degli anticorpi. Interazione antigene-anticorpo. Classi di Immunoglobuline e caratteristiche Isotipo specifiche. Funzioni degli anticorpi: gli anticorpi di membrana come recettore per l'antigene dei linfociti B; Neutralizzazione; Attivazione del Complemento; Opsonizzazione e Fagocitosi; Citotossicità Cellulare Anticorpo-Dipendente. -COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITÀ (MHC)- Organizzazione dei geni MHC. Struttura, funzione, distribuzione cellulare e regolazione dell'espressione delle molecole MHC di classe I e di classe II. Caratteristiche delle interazioni dei peptidi con le molecole MHC. -PROCESSAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ANTIGENE AI LINFOCITI T- Caratteristiche degli antigeni riconosciuti dai linfociti T. Cellule che presentano l'antigene (APC). Ruolo delle APC nell'attivazione dei linfociti T. Biologia cellulare della processazione dell'antigene. Meccanismi di processazione e presentazione degli antigeni esogeni in associazione con MHC-II ai linfociti T CD4+. Processazione e presentazione degli antigeni endogeni in associazione con MHC-I ai linfociti T CD8+. Significato fisiologico della presentazione dell'antigene in associazione con MHC. -RECETTORE PER L'ANTIGENE DEI LINFOCITI T (TCR)- Struttura e funzioni del TCRalfa/beta. Struttura e funzioni del complesso CD3 e proteine Zeta, dei corecettori CD4 e CD8, dei costimolatori e inibitori: CD28, CTLA4 e PD1. -RISPOSTA IMMUNITARIA CELLULO-MEDIATA- Migrazione delle APC e dei linfociti T naive negli organi linfoidi secondari. Riconoscimento antigene. Interazioni cellulari e priming delle cellule T naive. Trasduzione del segnale. Attivazione e differenziazione della sottopopolazione di linfociti T helper (Th) (Th1, Th2, Th17): ruolo e funzioni delle citochine coinvolte nella differenziazione dei Th. Attivazione macrofagica da Th1 e funzioni effettrici Th1. Attivazione di eosinofili e macrofagi da Th2 e funzioni effettrici Th2. Funzioni effettrici Th17. Attivazione, differenziazione e funzioni effettrici dei linfociti T citotossici. Meccanismi di citotossicità. -RISPOSTA IMMUNITARIA UMORALE- Riconoscimento dell’antigene e attivazione dei linfociti B. Trasduzione del segnale. Successione di eventi nelle risposte anticorpali verso antigeni timo-dipendenti. Caratteristiche, differenziazione e funzioni dei Th follicolari nella attivazione dei linfociti B. Interazioni e segnali tra cellule T e cellule B. Reazioni del centro germinativo: i) scambio di classe e meccanismi molecolari; ii) maturazione dell'affinità: mutazioni somatiche e meccanismi molecolari, selezione cellule B nei follicoli; iii) differenziazione dei linfociti B effettori e memoria. Risposte anticorpali verso antigeni timo-indipendenti. -IMMUNITÀ NEL SISTEMA GASTROINTESTINALE- Immunità innata nel tratto gastrointestinale. Immunità adattativa nel tratto gastrointestinale. Regolazione delle immunità nel tratto gastrointestinale da parte delle cellule T regolatorie e delle citochine. Tolleranza orale e vaccini orali. Il ruolo del microbioma commensale nella regolazione immunitaria. Malattie correlate alle risposte immunitarie nell'intestino. -TOLLERANZA IMMUNOLOGICA- Caratteristiche generali della tolleranza al self. Meccanismi di tolleranza centrale e periferica dei linfociti T e B. -MALATTIE CAUSATE DA ALTERAZIONI DELLE RISPOSTE IMMUNITARIE – AUTOIMMUNITÀ- Meccanismi cellulari e molecolari di autoimmunità. Perdita dei meccanismi responsabili della tolleranza al self. Alterazioni linfocitarie coinvolte nell’autoimmunità. Fattori genetici nell’autoimmunità. Fattori ambientali nell’autoimmunità. Ruolo delle infezioni nell’autoimmunità. Malattie autoimmuni organo-specifiche e sistemiche: meccanismi immunitari effettori responsabili del danno cellulare e tissutale. Esempi di malattie autoimmuni umane. -MALATTIE CAUSATE DA ALTERAZIONI DELLE RISPOSTE IMMUNITARIE –IPERSENSIBILITÀ- Basi immunologiche delle malattie di ipersensibilità. Fase di sensibilizzazione e di scatenamento delle reazioni di ipersensibilità. Meccanismi di danno cellulare e tissutale. -IPERSENSIBILITÀ DI I° TIPO O IMMEDIATA- Sensibilizzazione e produzione di IgE. Natura degli allergeni. Fattori genetici e ambientali. Attivazione dei linfociti Th2. Meccanismi effettori delle reazioni di Ipersensibilità di I° tipo: ruolo delle IgE, ruolo ed attivazione dei mastociti, basofili e eosinofili. Mediatori derivati da mastociti, basofili ed eosinofili e loro effetti. Risposte precoci e tardive. Esempi di patologie a base allergica nell’uomo. -IPERSENSIBILITA’ DI II TIPO- Meccanismi del danno causato dagli anticorpi citotossici. Principali manifestazioni: reazioni trasfusionali, anemia emolitica del neonato, anemia da farmaci. -IPERSENSIBILITA’ DI III TIPO- Meccanismi del danno causato dagli immunocomplessi circolanti. Fattori che determinano la patogenicità degli immunocomplessi. Principali manifestazioni di ipersensibilità di III tipo: reazioni localizzate (reazione di Arthus) e reazioni sistemiche (malattia da siero). - IPERSENSIBILITA’ DI IV TIPO- Fase di sensibilizzazione: attivazione dei macrofagi; attivazione e migrazione linfociti Th1; citochine. Meccanismi di danno tissutale causato dai linfociti TH1 e CTL. Esempi di patologie umane causate da ipersensibilità di tipo ritardato: dermatite da contatto, reazione di tipo tubercolinico, ipersensibilità granulomatosa. -IL TRAPIANTO ALLOGENICO- Basi molecolari e cellulari del riconoscimento allogenico. Risposta immunitaria al trapianto allogenico. Meccanismi effettori del rigetto: rigetto iperacuto; rigetto acuto; rigetto cronico. Prevenzione e trattamento del rigetto dei trapianti. Trapianto di midollo osseo. Malattia da reazione del trapianto verso l’ospite. -IMMUNITA’ E TUMORI- Antigeni tumorali e immunogenicità delle cellule tumorali. Meccanismi effettori dell’immunità contro i tumori: risposte innate e specifiche. Meccanismi di evasione della risposta immune da parte dei tumori. Immunoterapia dei tumori. Stimolazione delle risposte antitumorali dell’ospite: vaccini antitumorali. Immunoterapia passiva con linfociti T ed anticorpi. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | 3- Salute e Benessere 4- Istruzione di qualità |